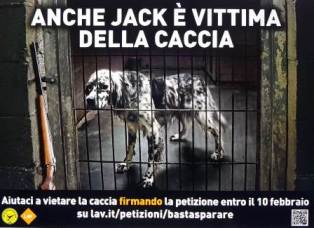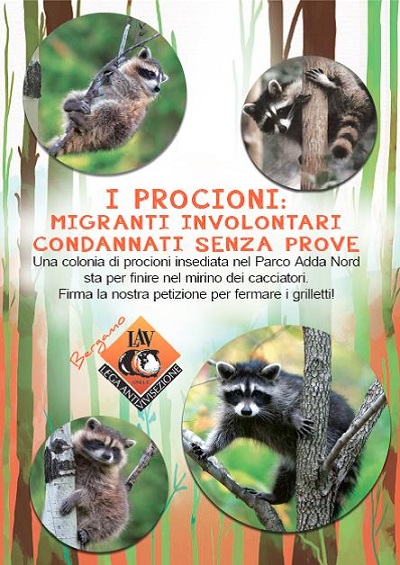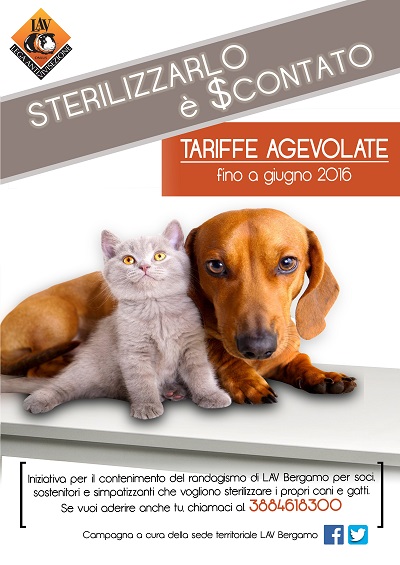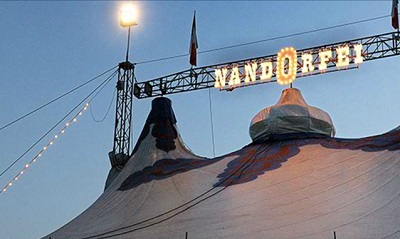Campagna informativa per sensibilizzare le amministrazioni comunali e i cittadini sui danni dei fuochi artificiali e dei palloncini
12/10/2022Fuochi artificiali e palloncini sono ampiamente utilizzati in feste pubbliche e private e ancora oggi particolarmente apprezzati. Eppure, sono da ascrivere tra le attività meno sostenibili e...